Il reinserimento sociale delle persone detenute: neuroscienze, epigenetica e welfare
Titolo Rivista WELFARE E ERGONOMIA
Autori/Curatori Luca Muglia, Aurora Maria Di Leverano
Anno di pubblicazione 2025 Fascicolo 2024/2
Lingua Italiano Numero pagine 19 P. 157-175 Dimensione file 101 KB
DOI 10.3280/WE2024-002011
Il DOI è il codice a barre della proprietà intellettuale: per saperne di più
clicca qui
Qui sotto puoi vedere in anteprima la prima pagina di questo articolo.
Se questo articolo ti interessa, lo puoi acquistare (e scaricare in formato pdf) seguendo le facili indicazioni per acquistare il download credit. Acquista Download Credits per scaricare questo Articolo in formato PDF
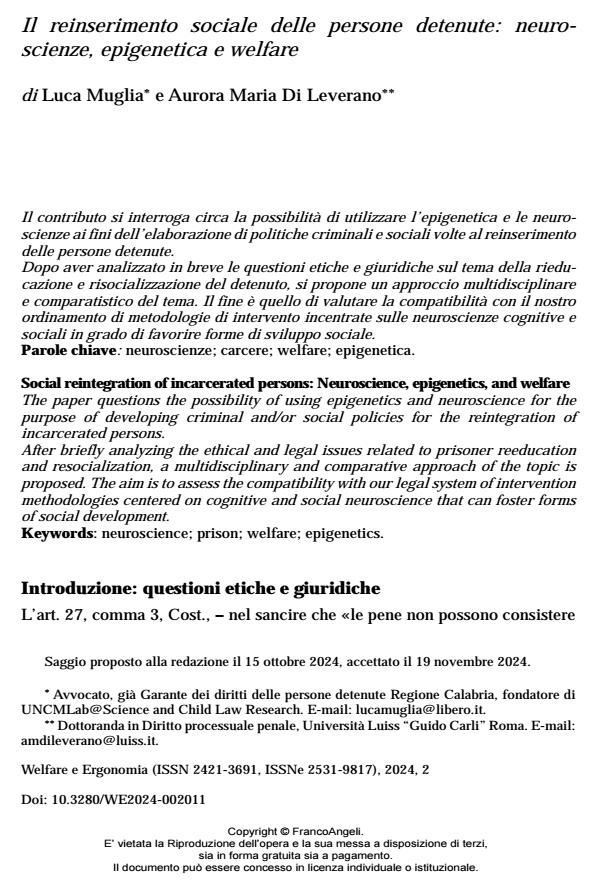
FrancoAngeli è membro della Publishers International Linking Association, Inc (PILA), associazione indipendente e non profit per facilitare (attraverso i servizi tecnologici implementati da CrossRef.org) l’accesso degli studiosi ai contenuti digitali nelle pubblicazioni professionali e scientifiche.
Il contributo si interroga circa la possibilità di utilizzare l’epigenetica e le neuroscienze ai fini dell’elaborazione di politiche criminali e sociali volte al reinserimento delle persone detenute. Dopo aver analizzato in breve le questioni etiche e giuridiche sul tema della rieducazione e risocializzazione del detenuto, si propone un approccio multidisciplinare e comparatistico del tema. Il fine è quello di valutare la compatibilità con il nostro ordinamento di metodologie di intervento incentrate sulle neuroscienze cognitive e sociali in grado di favorire forme di sviluppo sociale. Long abstract
Parole chiave:neuroscienze; carcere; welfare; epigenetica.
Luca Muglia, Aurora Maria Di Leverano, Il reinserimento sociale delle persone detenute: neuroscienze, epigenetica e welfare in "WELFARE E ERGONOMIA" 2/2024, pp 157-175, DOI: 10.3280/WE2024-002011