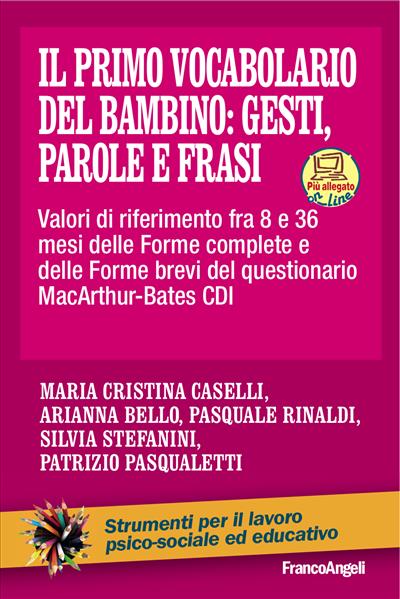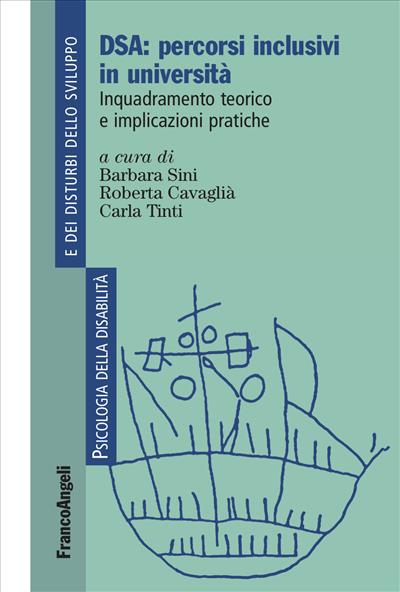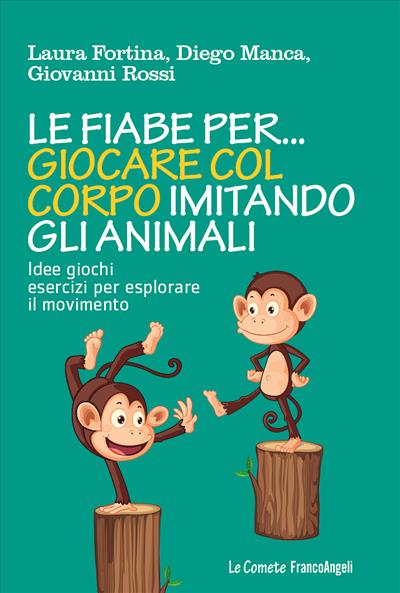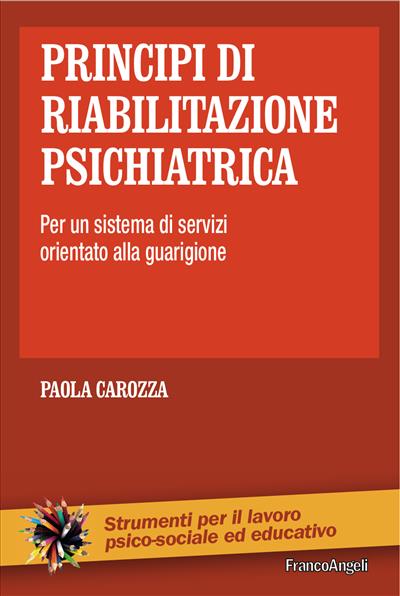
Principi di riabilitazione psichiatrica
Per un sistema di servizi orientato alla guarigione
Il volume fornisce un’aggiornata ed esaustiva panoramica sui principi, le finalità e le aree di intervento della riabilitazione psichiatrica. Il testo si sofferma sul processo riabilitativo, sul ruolo delle famiglie e sulle competenze che gli operatori devono maturare e fornisce una raccolta sistematica di linee-guida che orientino gli operatori nella pratica quotidiana e colmino un vuoto nella formazione dei professionisti.
Pagine: 500
ISBN: 9788846471932
Edizione: 11a ristampa 2025, 1a edizione 2006
Codice editore: 1305.70
Disponibilità: Discreta